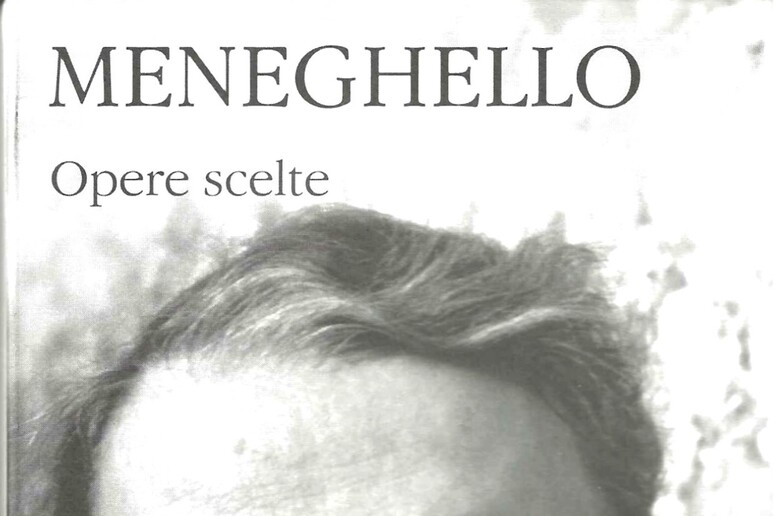Paolo Petroni Avendo vissuto dal 1947 in Inghilterra, dove ottenne un incarico e poi dal 1964 all'84 la cattedra di Letteratura italiana all'università di Reading, dove creò e diresse il Dipartimento di Studi Italiani, Luigi Meneghello, narratore, linguista, studioso di cui si celebrano i cento anni dalla nascita, avvenuta il 16 febbraio 1922 a Malo, in provincia di Vicenza, ha raccontato di aver capito come scrivere i suoi racconti in italiano grazie alla lingua inglese: ''Lo scopo della prosa non è principalmente l'ornamento, ma è di comunicare dei significati...
la solennità è un difetto'' e che l'oscurità come la complessità senza una ragione non è un pregio.
''Libera nos a malo'', il suo primo libro di narrativa del
1963 gioca nel titolo col nome del suo paese natale e sembra
indicare da subito come per lui fosse necessario liberarsi del
fardello di tanta tradizione fraintesa e retorica come dei
pregiudizi delle neoavanguardie verso la scrittura
autobiografica, che segnerà tutta la sua opera. Certo la sua
memoria è sobria, la scrittura misurata e elegante anche nelle
sue citazioni di dialetto (specie per oggetti, modi di dire,
canti), e non c'è compiacimento o nostalgia nella serenità del
suo raccontare, come non ce ne sarà traccia, abolendo ogni
cedimento retorico, nel libro ''I piccoli maestri'' dell'anno
dopo, in cui ricostruisce la sua esperienza nella Resistenza con
un gruppo militare del Partito d'Azione.
''S'incomincia con un temporale'' è l'inizio, con questo
annuncio subito coinvolgente, di ''Libera nos a malo'', che apre
ai ricordi con un ritorno a casa dove ascolta ''rumori noti,
cose del paese. Tutto quello che abbiamo qui è movimentato,
vivido, forse perché le distanze sono piccole e fisse come in un
teatro''. E l'idea di teatro in fondo aiuta a capire questo
raccontare letterario, colto e con sapienza filologica senza
alcuna supponenza, in cui il personale e famigliare, la semplice
vita di provincia diventano esemplari e veri, cogliendo in un
ricordo qualcosa che ha valore universale.
''I piccoli maestri'' è libro ''antieroico'' per eccellenza
dopo i tanti eccessi di esaltazione appunto eroica che segnarono
l'immediato dopoguerra. Si comincia anche qui col tornare sui
luoghi, con la propria ragazza, sull'altipiano di Asiago, e con
temporali. Ha cercato e ritrovato il parabellum che aveva
abbandonato sfuggendo a un rastrellamento e spiega: ''Non
eravamo mica buoni, a fare la guerra''. E in questa frase c'è il
senso del libro con tutta l'umanità di quei giovani partigiani,
forti solo delle proprie convinzioni, della necessità di darsi
da fare per cambiare le cose. Meneghello afferma di limitarsi
solo alla ''verità stessa delle cose, i fatti reali della
nostra guerra civile'', fatta anche quindi di stenti, paura,
ingenuità. Nasce così un'adesione assoluta e positiva a quella
realtà, anche attraverso la lingua, chiara, profonda,
fantasiosa, capace di passare dal momento comico a quello
commovente ma asciutto, così da far dimenticare l'io narrante
per restituirci un documento vivo, un esemplare racconto
storico.
Padre meccanico con un'autofficina e madre maestra,
Meneghello farà il liceo a Vicenza e l'università a Padova con
insegnanti che vanno da Norberto Bobbio a Concetto Marchesi. Nel
'43 è arruolato allievo ufficiale, ma dopo l'8 settembre, oramai
da tempo in contatto attivo con la Resistenza, si unisce a unità
combattenti e, col tempo, passa dall'Agordino ai Colli Berici e
all'Altipiano e nell'inverno del '44 organizza i Gap di Padova
con poi l'insurrezione della città alla viglia dell'entrata in
città degli alleati. Deluso negli anni seguenti dalla politica e
dai cambiamenti veri che non arrivano, decide di recarsi
all'estero e si trasferisce in Inghilterra dove ha vinto una
borsa di studio a Reading, che diverrà la sua casa sino alla
fine, tornando in ultimo spesso in Italia, tanto da morire nella
sua casa di Thiene il 27 giugno 2007, una settimana dopo la
laurea honoris causa all'Università di Palermo e in attesa di
ricevere il 6 luglio il premio Feltrinelli per la narrativa
dell'Accademia dei Lincei.
Dai ''Piccoli maestri'' passano dieci anni prima che
Meneghello torni a pubblicare, a riprendere i sondaggi delle sue
memorie con ''Pomo pero'' (1974), quasi una continuazione,
un'appendice sostanziale di ''Libera nos a malo'' con ricordi,
riflessioni sui morti e la morte e soprattutto la parte
intitolata ''Ur Malo'' che è una sorta di raccolta di termini
dialettali, composta in versi e poesie di gran suggestione e
suono, e ''Fiori italiani'' (1976) che si lega invece ai ricordi
resistenziali e da quelli va a ricostruire la formazione
culturale della sua generazione negli anni del fascismo,
analizzandone chiusura e testi sino alla scoperta dell'esistenza
di qualcos'altro, grazie all'incontro col professor Antonio
Giuriolo, cui poi si unirà per combattere in montagna. Tra tanti
saggi letterari e di linguistica, legati alla sua attività
accademica, c'è da citare ancora ''Bau-Sète'' del 1988 sui mesi
del dopoguerra sino alla decisione di espatriare, e ''Il
dispatrio'' del 1993. Tutto raccontato sempre con quella misura,
serenità e attenzione, tanto che Domenico Starnone, nel suo
scritto che introduce al Meridiano a cura di Giulio Lepschy
dedicato alle opere maggiori di Menghello, afferma: ''Meneghello
è uno scrittore che dà gioia. Chi legge i suoi libri diventa
lieto, ha l'impressione che il tempo non sia mai fuori squadra,
che i giorni scorrano bene, che non ci sia esperienza che non
abbia la luce giusta, che stare la mondo sia proprio una gran
bella cosa''.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA